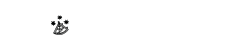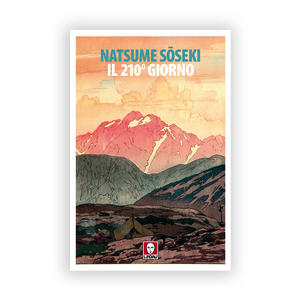«Nihyakutōka»: il 210° giorno del Giappone
Scritto da: Redazione
Dalla postfazione di Andrea Maurizi, traduttore e curatore de Il 210° giorno di Natsume Sōseki.
Andrea Maurizi è docente di lingua e letteratura giapponese all'Università degli Studi Milano-Bicocca. Ha tradotto, tra gli altri, Confessioni di una maschera di Yukio Mishima e il recente Fino a dopo l'equinozio di Sōseki.
Nihyakutōka ( Il 210° giorno) fu pubblicato nel 1906 nell’inserto del numero di ottobre della rivista «Chūōkōron».
Si tratta di un’opera liberamente ispirata a un’escursione sul monte Aso – il più grande vulcano attivo del Giappone – che Natsume Sōseki fece tra la fine di agosto e l’inizio di settembre del 1899 in compagnia dell’amico e collega Yamakawa Shinjirō (n. 1867). Gli eventi narrati in Nihyakutōka, scritto quasi per intero in forma dialogica, si svolgono nell’arco di un paio di giorni, e si incentrano sulla presentazione delle riflessioni a sfondo sociale, ma non solo, condotte da Kei e Roku, delle persone che incontrano nella locanda in cui soggiornano, su una minuziosa descrizione degli scenari naturali della regione e delle avverse condizioni meteorologiche in cui hanno la sfortuna di imbattersi e in seguito alle quali dovranno rinunciare al loro intento di raggiungere la sommità del cratere.
Il 210° giorno, forse a causa della sua brevità e dell’apparente inconsistenza e frammentarietà degli episodi che lo compongono, è stato a lungo sottovalutato dalla critica.
In realtà, diversamente da quanto potrebbe far pensare una rapida lettura, si tratta di un’opera nella quale l’autore, sfruttando una fitta rete di simboli e di rimandi storici e letterari, rappresenta allegoricamente il trauma vissuto dai suoi connazionali in seguito al processo di modernizzazione che, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, nel giro di pochi decenni modificò nell’intimo la fisionomia del paese.
Per rappresentare la forza dirompente del cambiamento sociale cui lui stesso fu testimone, Sōseki ricorre in quest’opera a due simboli appartenenti al mondo della natura: le tempeste che nel calendario lunisolare (wareki) preannunciavano il termine della stagione autunnale e l’eruzione del monte Aso.
Nel calendario lunisolare – abolito dal governo Meiji nel 1873 – c’erano due espressioni che indicavano le violente perturbazioni atmosferiche che potevano investire il paese nel corso dell’ultimo mese dell’autunno: la prima, nihyakutōka (lett. «il 210° giorno»), indicava le tempeste che si producevano duecentodieci giorni dopo l’inizio della primavera, quindi tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre; la seconda, nowaki (o nowake, lett. «erba divisa [dal vento]»), era invece usata per alludere ai tifoni che spazzavano il Giappone centro-meridionale tra il 220° e il 230° giorno dopo l’inizio della primavera, quindi nella seconda metà di settembre.
Riallacciandosi a una tradizione di origine continentale che interpretava le perturbazioni come manifestazioni con cui la natura palesava agli uomini l’insorgere di una profonda crisi storica o politica o un degrado morale della società, Sōseki si appropria del termine nihyakutōka per alludere alla violenza con cui le riforme attuate dall’oligarchia Meiji negli ultimi decenni del XIX secolo stravolsero le abitudini di vita della maggior parte dei giapponesi.
La scelta di ambientare la narrazione sul monte Aso non è casuale. Questo vulcano, oltre a essere il più grande del Giappone, è anche il rilievo su cui fu eretto nel III secolo d.C. lo Aso jinja, uno dei santuari shintoisti più antichi del paese, quello in cui si venerano Takeiwatatsu, nipote dell’imperatore Jinmu, e altri undici mitici componenti della casa imperiale. Il valore simbolico del luogo, legato alle origini della famiglia imperiale e della civiltà giapponese, è quindi molto alto. Con la sua eruzione esplosiva, il vulcano pone simbolicamente termine a un’epoca – quella del Giappone premoderno – e segna l’inizio di un nuovo importante capitolo della storia del paese. L’evocazione della forza distruttrice della natura in concomitanza di un momento di crisi o di un radicale mutamento delle condizioni storico-politiche, così come la dettagliata descrizione dell’intensità con cui la tempesta e l’eruzione vulcanica turbano la quiete e la bellezza della montagna, possono essere letti come un erudito rimando letterario al concetto di impermanenza (mujō) così come viene presentato all’interno di due capolavori della letteratura classica giapponese: il Genji monogatari (La storia di Genji) di Murasaki Shikibu (ca 973-ca 1014) e lo Hōjōki (Ricordi di un eremo) di Kamo no Chōmei (1153-1216), dove l’insorgere di violenti eventi meteorologici (tenpen) o di cataclismi naturali quali uragani e terremoti ricorda agli uomini che niente a questo mondo è immutabile, che tutto è destinato a trasformarsi e a passare.
Se l’ambientazione del racconto cela il desiderio dell’autore di rappresentare in chiave metaforica l’immane cambiamento storico vissuto dal Giappone sul finire dell’800 e gli inizi del ’900, le modalità con cui sono tratteggiati i due protagonisti possono ugualmente essere ricondotte alla volontà di ritrarre i caratteri distintivi dei fautori più estremi del rinnovamento sociale e dei difensori del modello tradizionale della società, o per lo meno dei rappresentanti meno intransigenti e reazionari della generazione nata intorno agli anni della Restaurazione Meiji. (…)
La vena umoristica che pervade quest’opera è stata a lungo quella maggiormente apprezzata dai lettori e dagli studiosi di Il 210° giorno, che per questa sua caratteristica è stato spesso interpretato come una testimonianza della passione di Sōseki per una scrittura dai risvolti comici che affondava le sue radici nelle arti declamatorie (wagei), in generale, e nei rakugo, in maniera più specifica. Il rakugo, una forma di declamazione umoristica basata su un dialogo ricco di giochi di parole, era senza dubbio l’arte recitativa di maggior successo nel periodo Meiji. Sōseki ne era un grande estimatore, e non perdeva occasione per andare ad assistere ai frequenti spettacoli messi in scena nei più importanti teatri stabili (yose) della capitale. Di questa sua passione si trovano tracce in tante sue opere, a cominciare dai dialoghi umoristici di Io sono un gatto (1905) fino alla disquisizione sulle caratteristiche recitative di Yanagida Kosan III (1856-1930) e San’yūtei En’yū (1849-1907) riportate in Sanshirō (1908) e ai ricordi di infanzia inclusi in Dietro la porta a vetri (1915).
Il rakugo rappresentò per Sōseki un’inesauribile fonte di ispirazione, e non solo per la caratterizzazione di personaggi e l’ambientazione di storie. Questa forma di intrattenimento popolare fornì allo scrittore anche la possibilità di costruire dei racconti fondati sul suo stesso equilibrio interno tra parti narrate e dialogiche, sui suoi stessi ritmi, sulle sue stesse battute e sui suoi stessi silenzi. Studi recenti hanno evidenziato le profonde connessioni che uniscono il rakugo ai dialoghi serrati e alla rappresentazione di episodi o personaggi secondari di Il 210° giorno. Il debito acceso da Sōseki nei confronti di quest’arte si rivela soprattutto nella scelta di scrivere un’opera sfruttando quasi esclusivamente la potenzialità espressiva del dialogo. Rapidi scambi di battute tra i personaggi, uso estensivo della lingua colloquiale di Tōkyō e intermezzi comici estrapolati dal repertorio classico del rakugo: questi gli espedienti narrativi e linguistici della tradizione delle arti declamatorie di cui Sōseki sfrutta le potenzialità per creare un racconto che solo apparentemente rappresenta il viaggio intrapreso da due ragazzi fino alla remota provincia di Kumamoto, nell’isola di Kyūshū, nel vano tentativo di ammirare la straordinaria bellezza del cratere del monte Aso.
Pubblicato un anno dopo l’uscita di Io sono un gatto e a pochi mesi di distanza da Il signorino e Guanciale d’erba (entrambi del 1906), Il 210° giorno non ha riscosso il successo di pubblico delle opere più lunghe e strutturate dell’autore. Eppure, anche se con modalità diverse rispetto ai suoi lavori più acclamati, anche in questo racconto Sōseki riesce a coniugare con estrema maestria la sensibilità della cultura tradizionale giapponese con le tecniche narrative di matrice occidentale. Manipolando a suo piacimento fonti di diversa natura, con Il 210° giorno Sōseki crea un’opera che, a dispetto delle ridotte dimensioni, illustra – a volte in maniera evidente, altre con modalità più indirette – uno dei momenti più difficili e traumatici della storia del paese. I riferimenti letterari e le allusioni al repertorio del rakugo e alla letteratura di intrattenimento del XIX secolo conferiscono all’opera la solidità che solo la tradizione è in grado di assicurare, impreziosendo e nobilitando un racconto che ben si presta a rappresentare lo spessore intellettuale e l’originalità di uno degli scrittori giapponesi più conosciuti e amati in Occidente.
--
Il libro
Il 210° giorno
di Natsume Sōseki
a cura di Andrea Maurizi