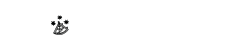Egregio Signor Villaggio
Scritto da: Redazione
Estratto dal libro «Fantozzi. Una maschera italiana». La lettera che qui pubblichiamo risale al 2003: l'autore, Fabrizio Buratto, la riporta a inizio saggio. In fondo si può scaricare l'intervista che Buratto cita in questa lettera e che fece a Paolo Villaggio dal febbraio del '98.
Egregio Signor Villaggio,
come già fece Fantozzi (in apertura del Secondo tragico libro di Fantozzi esternava alcune considerazioni sul suo conto, appellandosi al «Direttore Amministrativo del libro» affinché non lo facesse uscire), vorrei, in apertura di questo saggio cui mi sono dedicato con molto piacere e partecipazione, scriverle una lettera. Premesso che la considero, oltre che un grande attore, una persona intelligente, che stimo, mi permetta di esprimere alcune personali impressioni.
La prima volta che la incontrai fu, il 10 febbraio del ’98, in un camerino del Teatro Della Corte di Genova: aveva la barba e i capelli bianchi lunghi. Si stava apprestando a essere truccato da «avaro», dovendo interpretare l’omonima opera di Molière; erano circa le venti e mi aveva dato appuntamento per le diciannove. «Vieni domani mattina alle dieci, ormai è tardi.» Presi il primo treno per Alessandria, per ritornare a casa. Ero un po’ stanco dal momento che mi trovavo a Genova fin dalla mattina, ma era stata una bella giornata di sole, piacevole specialmente per chi, come me, non è abituato al clima della Riviera.
Il mattino successivo, alle ore dieci, la feci chiamare nella sua stanza del President Star Hotel; mi comunicarono di attenderla. Passata un’ora incominciai a dubitare di aver capito: avrei forse dovuto raggiungerla nella sua camera? Chiesi informazione alla reception che la richiamò: «Vuole parlare con lei», mi disse il portiere offrendomi il ricevitore del telefono. «Non sono mica pagato.» Era la sua voce, profonda e inconfondibile. Poco dopo scese, mi avvicinai per spiegarle che forse non avevo capito bene. «Hai capito benissimo», fu la risposta lapidaria. Pensai in maniera fantozziana: «Non c’è speranza». Frattanto si era fatto avanti un signore ben vestito, che avevo notato, al mio arrivo, leggere il giornale su di una poltrona: era il suo autista. Salimmo in macchina, una lussuosa Mercedes blu scuro: «In via San Vincenzo», ordinò lei. Entrammo nella pasticceria Panarello. «È contento di essere qui, nella sua città?», le domandai. «No», fece lei bruscamente. Nella pasticceria, mentre beveva il cappuccino, comprò due torte di cui non ricordo il nome, specialità genovesi. Parlava a voce bassa, mangiandosi un po’ le parole e la signora che la stava servendo non capiva quello che diceva; lei, indispettito, glielo ripeteva sillabando. Quando apprese che il negozio non disponeva di un corriere per la spedizione dei pacchi si inalberò; afferrò bruscamente le torte e uscì. La medesima signora mi guardò esterrefatta, come se avessi dovuto spiegarle il motivo di tale comportamento.
Subito dopo entrò, di fronte a Panarello, nella focacceria Mario, stracolma di clienti: donne che compravano il pane, ragazzi appena usciti da scuola affamati di focaccia, che la guardarono sbalorditi e la fecero passare.
Il suo abbigliamento non passava certo inosservato, in particolar modo dalla cintola in giù: pantaloni a strisce blu e bianche con ricamini floreali stile pigiama hawaiano, scarpe da ginnastica nere, senza calze. Si fece tagliare due abbondanti pezzi di focaccia con le cipolle (sarebbe piaciuta anche a Fantozzi, goloso com’è di «frittatura con le cipolle») e ne pretese subito un assaggio. Risalimmo in auto all’affannosa ricerca di un corriere espresso. In questa circostanza vittima della sua scontrosità fu l’autista, reo di non sapere quale fosse quello migliore, ma ne raggiungemmo presto uno. Quei pacchi erano per Maura, sua moglie; una volta sicuro che avrebbe ricevuto i dolci al più presto si tranquillizzò. Risaliti in macchina, l’autista le domandò: «Al Santa Chiara?». «E certo, il posto più bello del mondo.» Poco dopo scoprii che il Santa Chiara era un ristorante e il posto più bello del mondo il porticciolo di Boccadasse. Sedemmo sulla terrazza. Sembrava una giornata di maggio: i gabbiani volteggiavano nel cielo stridendo, le onde si infrangevano sugli scogli sotto di noi. Si fece tagliare la focaccia in piccoli quadrettini: il suo umore era cambiato, rispondeva alle mie domande in modo pacato, e il senso di fastidio che mi aveva fino ad allora provocato si era dissolto. Distratto di tanto in tanto dai Canadair che si abbassavano a prelevare l’acqua per spegnere gli incendi divampati nell’entroterra, fu veramente esauriente quando capì che il mio interesse era autentico, così come approfondito lo studio che stavo conducendo.
Il narcisismo dell’attore fece il resto, ma quando, dopo circa un’ora, la fame riprese il sopravvento e l’arrivo degli amici che attendeva per il pranzo si fece imminente, le risposte divennero più concise. La ringraziai per la disponibilità, dimostratami anche lasciandomi i suoi numeri telefonici di casa e del portatile, ma purtroppo non avevo esaurito le domande. Mi promise che ci saremmo rivisti a settembre, durante la Mostra del Cinema di Venezia.
A Venezia rimandò l’appuntamento di giorno in giorno, per una settimana: alla fine mi disse che non aveva proprio il tempo. «Sarebbe questione di mezz’ora», aggiunsi per tranquillizzarla. «Non è proprio questione; comunque prima di morire la facciamo.»
E siamo alla fine di novembre. Leggo sul «Secolo XIX» che sarà a Genova per Il vizietto e che si fermerà una quindicina di giorni. La chiamo, lei mi dice di farmi sentire il giorno successivo, ma trovo la segreteria telefonica: decido di prendere ugualmente il treno per Genova. Treno che accumula un ritardo «agghiacciante» ma, abituato a simili disguidi, non mi perdo d’animo. La vengo a cercare al solito hotel, dove mi dicono invece che la troverò al Jolly Hotel, vicino al Teatro Genovese dove va in scena lo spettacolo. Mi dirigo quasi correndo per la salita che conduce a piazza Corvetto, entro al Jolly con il fiatone e per poco non mi incastro nella porta girevole dell’albergo. «Il signor Villaggio è uscito da poco.» Le lascio un biglietto in cui le scrivo che mi rifarò vivo. La domenica successiva mi fa sapere che ci saremmo visti mercoledì 25 novembre.
Il fatto di avere il numero del suo telefonino, di contattarla mentre non so dove si trovi né cosa stia facendo, mi infastidisce. Mi sento uno scocciatore, mi pare di essere assillante e non mi piace. Alle nove e mezza sono all’albergo; ho appreso dal «Secolo XIX» che lei, in mattinata, farà visita alla sua vecchia scuola e sono un po’ preoccupato. Alle dieci e quarantacinque scende con sua moglie, mi saluta cordialmente: «Adesso però dobbiamo andare al D’Oria». Raggiungo a piedi il liceo, assediato da televisioni e giornalisti; lei è appena arrivato – evidentemente ha già fatto un salto in via San Vincenzo. La visita è piacevole: aneddoti e provocazioni secondo il suo stile, ma le ultime parole che rivolge agli studenti radunatisi nell’aula magna sono commoventi:
«Vi invidio molto perché state vivendo un attimo che va via veloce, però questo è il momento più felice della vostra vita».
Le si rompe la voce, la commozione è sincera e io l’apprezzo, come avevo apprezzato il gesto di inviare i dolci a sua moglie. In seguito mi dice di non avere tempo per l’intervista, e mi prega di tornare il giorno successivo «perché ci tengo e ti voglio dedicare... due ore», e in quel «due ore» è avvertibile un’inflessione fantozziana. Il giorno dopo, «implacabile», eccomi di ritorno al Jolly. Mi dicono che ha staccato il telefono della camera e la chiamo al cellulare. «Adesso sta dormendo», è la voce di sua moglie Maura. Riprovo alle undici, dopo aver ingannato l’attesa con un pezzo di focaccia al formaggio, e lei mi dice di attenderla. Scende a mezzogiorno, la sua segretaria le ricorda che deve recarsi in banca e che successivamente ha un’intervista con «Il Secolo XIX». Prima di salire in auto mi rivolgo a lei: «Le prometto che poi non la scoccerò più, mi rendo conto che lei ha molti impegni...». «Non mi scocci, ho tanti impegni come tutti quelli che fanno questo mestiere di merda.»
Avverto nuovamente una spiacevole sensazione di fastidio. In auto mi chiede di leggere le domande: «Sono domande difficili, mi mettono in imbarazzo». In effetti alcune sono «politiche», altre profondamente personali e hanno lo scopo di indagare meglio la maschera che lei ha creato.
Il suo portatile continua a squillare, anche lei deve chiamare parecchie persone, e oltre che nei confronti dell’autista si dimostra insofferente pure verso sua moglie, che, seduta di fianco a me sui sedili posteriori, la esorta: «Sì, ma Paolo, calmati!». Dopo la banca, via San Vincenzo e la focaccia con le cipolle, torniamo in hotel. Ad attenderla ci sono due giornalisti del «Secolo XIX» per un’intervista sull’omosessualità, il soggetto del Vizietto.
Trascorsa una quarantina di minuti, decide di andare a pranzo con i giornalisti. «Io l’aspetto qui.» «Va bene, fra un’ora e mezza torno.» Erano le quattordici.
Alle sedici e un quarto la vedo apparire e mi alzo dalla comoda poltrona sulla quale mi ero quasi addormentato.
«Adesso sono scoppiato, non ce la faccio. Ci vediamo più tardi, alle sei e mezza, oppure vieni domani, o ti ospito qui, o...»
«Se mi assicura che alle sei e mezza scende l’aspetto, domani dovrei lavorare...»
«Va bene, ci vediamo alle sei e mezza.»
Ormai, sprofondato su una poltrona del salottino del Jolly, ho letto quasi tutto il giornale, mi butto sullo sport e sull’economia anche se non mi interessano. Ho un «leggero appetito» dal momento che, dopo la focaccia al formaggio, non ho mangiato più nulla. Di tanto in tanto passa un fattorino e mi lancia un’occhiata; nell’aria aleggia della musica classica, le pareti sono beige, il soffitto bianco panna, e mi pare di trovarmi in uno di quei centri dove si pratica l’eutanasia di cui ho appena letto. A questo punto la sua voce fuori campo, quella che compare nei film di Fantozzi, commenterebbe:
«Erano le diciannove e trentacinque. Dopo 5h, 35’e 15’’ d’attesa, record non omologato, ma mai superato, il Nostro decise di andarsene e si alzò. Salutò educatamente il fattorino, che lo guardò come se fosse un pazzo pericoloso, e se ne uscì rischiando di rimanere vittima di quella trappola tremenda che è la porta girevole».
Ora, mentre le scrivo, mi trovo sul «clamoroso» treno regionale per Alessandria «via Busalla Isola», che si ferma anche nei boschi e ci mette due ore. Sono certo che, qualora mi facessi ancora vivo, riuscirei a incontrarla e a finire l’intervista, ma – perdoni la mia ingenuità – mi piace pensare a lei come Fantozzi, e perciò mi imbarazzerebbe, nel rivederla, provare ancora quel senso di fastidio... Fra le altre cose avrei voluto domandarle se si reputa felice. A me pare – non la sto giudicando – che, essendo una persona molto sensibile e, soprattutto, un comico, l’accompagni un «alone nero» che la rende profondamente infelice. La sua intelligenza e il suo senso critico non mi sembrano sufficienti a sfatare quel luogo comune, che devo pensare non sia tale, secondo il quale nell’animo di ogni grande comico alberghi l’infelicità.
Dunque, non me ne voglia, ma alle domande che avrei voluto farle ha risposto con la sua persona e, lungi dal provare nei suoi confronti i sentimenti di Fantozzi, che scrive di odiarla con tutto il cuore, preferisco comunque Fantozzi a lei, perché mi fa ridere ed è felice, nonostante tutto.
Sinceramente,
Fabrizio Buratto
---
|
|
Fabrizio Buratto Fantozzi. Una maschera italiana Fuori catalogo |