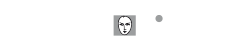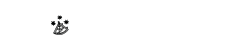Diario editoriale #48: leggiamo Leopardi per progettare il futuro
Scritto da: Ezio Quarantelli
Ieri sera ho incontrato Maurizio Pallante (per la serie dei nostri incontri intitolati “Il bicchiere della staffa”) per ragionare intorno al suo libro più recente: Ultima chiamata. Cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci. Provo molta ammirazione e gratitudine per il bellissimo lavoro – informato, rigoroso, profondo – che Maurizio sviluppa da anni. Lui è uno dei pochi in Italia che affronta i problemi alla radice, senza accontentarsi di qualche ragionamento consolatorio.
Il punto è chiaro: qualunque forma di difesa dell’ambiente si rivelerà nel tempo inefficace se non sarà messo in discussione il nostro modo di concepire la produzione, l’economia e molte forme della nostra vita associata. In altre parole, se non cambieremo la prospettiva da cui immaginiamo e prepariamo il futuro.
Non è certo sbagliato promuovere a tutti i livelli una serie di pratiche virtuose che possono limitare i danni (o sembrano poterlo fare). E non è neppure sbagliato contare sulla capacità della ricerca scientifica e della tecnologia di aiutarci a trovare forme meno invasive per abitare il pianeta.
Per rovesciare la situazione serve però un cambio di paradigma che ci permetta di riconsiderare il nostro posto nel mondo e di riconfigurare la nostra scala di valori.
Come Pallante sostiene, destra e sinistra sono condizionate da un modo di concepire l’economia che si basa su presupposti analoghi, anche se poi arrivano evidentemente a conclusioni diverse. Tutto ruota sempre intorno allo sviluppo e alla crescita, due “dogmi” tutto sommato recenti, e non l’espressione di verità eterne. Non è un caso che la misura più spesso adottata per capire che cosa succede e per stabilire degli obiettivi sia esclusivamente quantitativa: il PIL infatti cresce pure quando si producono più armi o aumenta il numero degli incidenti stradali. Ma sviluppo e crescita conducono inesorabilmente a un sempre più intenso sfruttamento delle risorse con tutto ciò che questo comporta.
Il libro di Pallante – che vi invito a leggere e a far leggere – si apre con un bellissimo testo leopardiano, il “Dialogo di un folletto e di uno gnomo”. Il dialogo avviene dopo che si è compiuta l’estinzione della specie umana, di quella specie che aveva creduto che il mondo esistesse soltanto in sua funzione. Ma ora che non c’è più “la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non sono stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si vede che si rasciughi”. E “le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non hanno preso le gramaglie”. Fosco, ma istruttivo presagio.